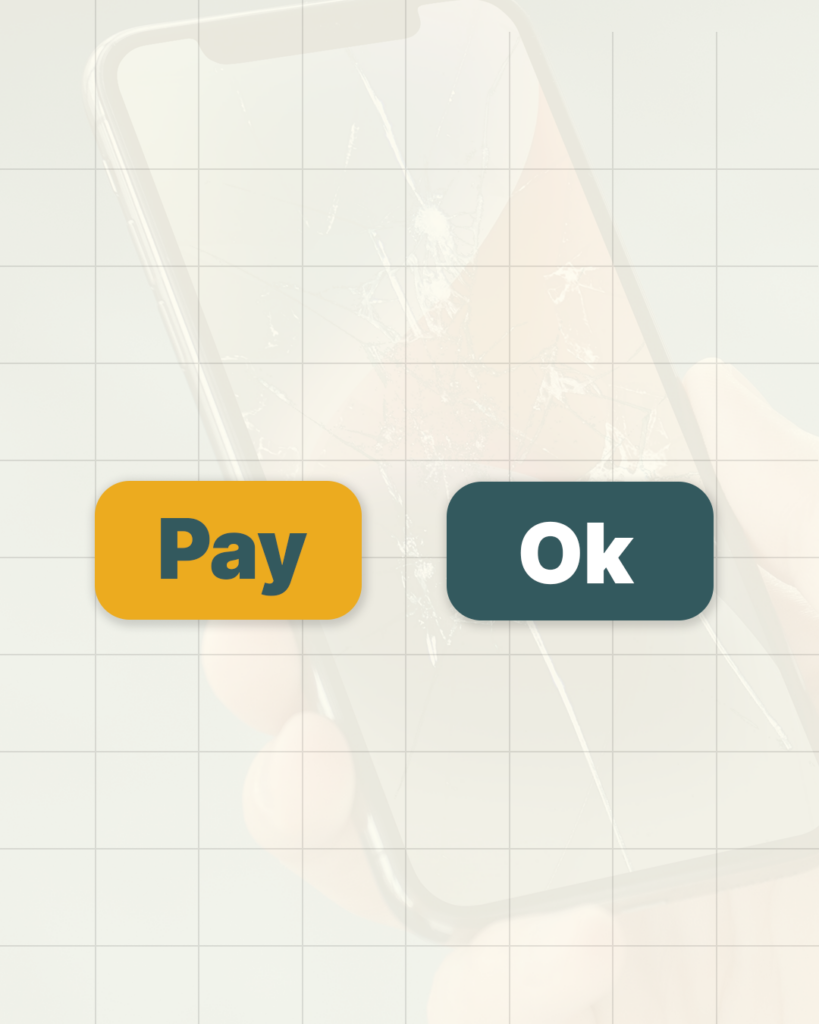Youtube blocca il canale del regista e attivista Oliver Ressler
1 Settembre 2021


Settembre 1, 2021
3933 Views
Autrice: Lorenza Saettone
Il 2 agosto il canale Youtube dell’artista viennese Oliver Ressler, noto per aver prodotto centinaia di film di critica e consapevolezza su temi quali discriminazioni, diritti, ecologia e lotta al capitalismo, è stato cancellato dalla piattaforma senza preavvisi.

I motivi di questa eliminazione?
“We have reviewed your content and found severe or repeated violations of our Community Guidelines. Because of this, we have removed your channel from YouTube. […] Spam, scams or commercially deceptive content are not allowed on YouTube”.
Nel canale c’erano 31 pellicole realizzate dal 2000 al 2018 e apparse in festival, manifestazioni, musei come quello Reina Sofia di Madrid.
Insomma, nulla che potesse essere catalogato come truffa, spam e contenuti ingannevoli. Il punto è che nell’attesa che i video rimossi da Youtube fossero ricontrollati, a seguito della pronta contestazione inviata dall’artista, il canale è rimasto chiuso per giorni e, come se non bastasse, da Google tutto taceva.
Dopo più di una settimana dal ricorso inviato da Ressler e articoli che denunciavano il fatto, Youtube, infine, riattivò l’account, senza tuttavia precisare i motivi per cui la piattaforma mal interpretò quei contenuti. Siamo di fronte all’ennesima censura preventiva attuata da Youtube.
Presunzione di colpevolezza
Google e le altre grandi compagnie tecnologiche quando cancellano alcuni contenuti, sponsorizzando disinformazione e odio, lo fanno davvero accidentalmente? O, piuttosto, dietro simili errori c’è un algoritmo costruito ad hoc per “sbagliare”? I post con hashtag “Black lives matter”, “supporting black people”, “supporting black voices” e “supporting Black success” sono stati ripetutamente segnalati da Tik Tok come contenuti inappropriati, mentre le “versioni bianche” delle stesse frasi no, come riportato dal MIT a luglio.
Più che semplici sviste e coincidenze sembra che la trama segua un metodo preciso, intenzionale.
Youtube tende ad applicare il criterio della presunzione di colpevolezza, nel senso che ogni utente è giudicato colpevole fino a prova contraria, al contrario di ciò che dovrebbe accadere. Nel nostro ordinamento la presunzione d’innocenza tutela la libertà individuale, impedendo l’applicazione della pena prima della condanna definitiva. Questa può avvenire solo se l’accusa riesce a dimostrare, con prove, la colpevolezza. All’imputato, invece, non è richiesto di dimostrare la sua innocenza, essendo, per l’appunto, data per presupposta. Questo principio non vuol dire che non siano adottabili misure cautelari, preventive, ma Youtube pare preferisca commissionare la pena e aspettare che l’utente faccia eventualmente ricorso.

Dipende tutto da che rischio si preferisce correre: punire un innocente o lasciare libero un colpevole. Youtube è conscio dei molti errori di valutazione del suo algoritmo, eppure sceglie di seguire la linea dura adottata fino ad ora, censurando preventivamente ogni contenuto su cui esiste anche solo un minimo sospetto. C’è da dire che il confine tra moderazione e censura è labile e in un contesto come il web, in cui un video può essere visto milioni di volte in pochi secondi, bloccare prima, e solo dopo prendersi del tempo per riconsiderare tale decisione potrebbe essere il male minore. Ovviamente, sempre che ci sia il tempo per ricontrollare.
C’è comunque il dubbio che dietro questi errori ci sia qualcosa di più.
A giugno il canale Atajurt Kazakh Human Rights subì una sorte simile a quella di Ressler: blocco e riattivazione solo di alcuni filmati. In questo caso si tratta di testimonianze provenienti dalle famiglie kazake dei soggetti chiusi nei campi di rieducazione in Cina.
Google aveva motivato le sue scelte dicendo che i video stavano violando la privacy dei soggetti ripresi. In seguito ha risposto che i filmati stavano infrangendo una norma che impedisce di tessere le lodi di organizzazioni criminali. Com’è possibile che le famiglie dei musulmani perseguitati in Cina siano state riconosciute come gruppi terroristici? Anche Facebook qualche mese prima aveva bloccato il profilo di Atajurt. Secondo Asian News l’azienda di Zuckerberg mirerebbe a entrare nel mercato cinese e per farlo non può che sottostare ai diktat del governo mandarino, tra cui il divieto assoluto di parlare delle persecuzioni ai danni degli uiguri.
Il monopolio delle Big Tech
Youtube e le altre Big Tech esercitano la propria legge in virtù del monopolio tecnologico che detengono. Non essendoci competizione, possono decidere quale sia il confine della giustizia a loro uso e consum… ismo.
Ressler prima della pandemia non aveva mai caricato i suoi video di denuncia politica su Youtube, preferendo Vimeo, dove, infatti, non è mai stato bloccato.
Lo scorso anno decise di caricare le proprie pellicole anche sulla piattaforma di proprietà Google, per aumentare la visibilità intorno ai temi che trattava e raggiungere target che normalmente non avrebbe colpito. In effetti è proprio durante la pandemia che le grandi aziende private di internet hanno prosperato, accentrando ancora di più il potere nelle loro mani.
Nel Medioevo, dopo il periodo di anarchismo feudale, nell’istante in cui i sovrani ripresero centralità dando forma agli Stati Nazionali, emersero i parlamenti e le prime costituzioni con cui bloccare lo strapotere dei regnanti. Allo stesso modo è proprio nel momento di potere massimo delle big tech che i nostri governi stanno reagendo all’accentramento, opponendo regolamenti alle aziende della Silicon Valley.
Stabilire confini netti al monopolio di Apple, Amazon, Facebook e Google non è così semplice. Innanzitutto la diversità dei motivi per cui ognuna delle aziende violerebbe l’antitrust impedisce la redazione di norme generali, applicabili in modo ubiquo e immediato.
C’è da dire che la fiducia nutrita dalle persone resta alta (Facebook è un’eccezione): i benefici percepiti sorpassano i rischi, i quali spesso non sono avvertiti come reali: mere costruzioni ipotetiche, “what if”. Inoltre, bloccare le Big Tech potrebbe inizialmente comportare servizi peggiori e quindi una rischiosa perdita di consenso delle masse nei confronti dei governi intervenuti a depotenziare le aziende della Silicon Valley.
Oltretutto, il monopolio digitale odierno ha bisogno di nuove direttive, differenti da quelle che, per esempio, portarono a limitare la piovra Standard Oil nel 1911. Servono misure che regolamentino un monopolio spesso invisibile, quello dei dati e della pubblicità. È attraverso i big data che le piattaforme hanno guadagnato la propria posizione di predominio, potendo condizionare la politica, l’economia e le altre sfere sociali.
Digital Services Act
Biden, per frenare lo strapotere delle Big Tech, ha coinvolto nelle proprie decisioni noti critici, attivisti ed esperti di leggi antitrust come Lina Khan, con l’obiettivo di risolvere lo strapotere acquisito dalle Big Tech. Ad aver dato l’abbrivio a questa fase di intervento sul monopolio delle piattaforme digitali è l’Europa. Tuttavia, la strada verso una normativa che regoli il potere delle piattaforme digitali è lunga. L’Unione Europea è al lavoro sulla proposta del Digital Service Act (DSA), ma occorreranno ancora anni per avere un Regolamento definitivo.
Il DSA mira a tutelare la competitività e la crescita delle aziende più piccole. Al centro ci sono i diritti del pubblico e le responsabilità divise tra piattaforme online e governi, i quali, finalmente, potranno opporre un controllo più pervasivo sulla disinformazione e manipolazione delle informazioni, oltre che regolamentare in modo più rigoroso le misure di censura che le aziende di internet, forti dell’assenza di alternative nel mercato globale, mettono in atto. Come diceva Popper “democrazia” non significa scelta della maggioranza, ma esistenza di un’opposizione che possa esercitare il suo lavoro di controllo sul governo.
Le Big Tech fino ad ora hanno agito senza avere competitori (governi, associazioni di cittadini e altre aziende) che potessero partecipare alla dialettica della democrazia, dimostrando come qualunque assolutismo possa facilmente scordarsi dell’illuminazione e quindi del popolo.
Con il nuovo regolamento europeo le grandi piattaforme di internet dovranno garantire trasparenza, anche per gli algoritmi utilizzati. Dovranno collaborare con le autorità nazionali e gli audit esterni indipendenti, inserendo sempre i diritti fondamentali nelle policy. Dovranno fornire attività di sportello e, nel caso, di rappresentanza legale, assicurando che i meccanismi di reclamo e ricorso non cadano a vuoto e che i segnalatori siano attendibili.
Come si comprende, queste misure andrebbero a tutelare casi come quelli descritti precedentemente. Il canale di un artista non verrebbe più bloccato senza spiegazioni e senza concreti mezzi di reclamo. I motivi del blocco non potranno più rimanere imprecisati e nemmeno potrebbe restare oscurato un intero canale senza che il proprietario possa ricevere alcun avviso anticipato per le “ripetute e gravi violazioni”, di cui la mail faceva cenno sommario.
L’opzionalità e i benefici della competizione
A causa dei frequenti errori in cui incappano le piattaforme online, giudicando come inappropriati contenuti che invece sono totalmente in linea con le guidelines della piattaforma, gli utenti sono costretti a subire passivamente le ripetute censure. Il potere nasce sempre dall’opzionalità.
Avere più alternative e poter rifiutare quella che, secondo i nostri standard, si addice meno alla nostra scala valoriale, è garanzia di qualità e sicurezza. Youtube fa leva sull’assenza di alternative potenti ai servizi che offre. In questo modo esercita un’autorità hobbesiana sugli utenti, che, pur di beneficiare della visibilità e dei ritorni della piattaforma, accettano le ingiustizie perpetrate a loro danno. Un po’ come le piccole software house di Taiwan e Hong Kong che, in virtù dello strapotere rappresentato dal mercato cinese, si trovano costrette a scendere a compromessi altrimenti inaccettabili, mutilando, di conseguenza, la creatività.
Non è possibile che i game-play prevedano racconti dove le istituzioni siano malvagie, pena il blocco nel mercato mandarino, se non, addirittura, l’arresto dei creativi. Un team di sviluppo taiwanese, per esempio, è stato costretto a non includere il colore giallo nella propria palette cromatica, perché, dopo che a Hong Kong i manifestanti usavano ombrelli di quel colore per difendersi dal gas usato dalle forze dell’ordine, quella tinta è diventata un simbolo con cui riferirsi ai dimostranti pro-democrazia.
È chiaro che se ci fosse un aut aut interessante, i creativi avrebbero il potere di rifiutare il target-Cina per puntare ad altro. Se tutti potessero superare quelle barriere di monopolio, la Cina, restando sguarnita, non potrebbe che ammorbidire le sue pretese. Insomma, è la libertà di preferire una scelta piuttosto che un’altra a conferire potere nei confronti delle alternative stesse, giocando un contrappeso all’iniquità.
Il Digital Service Act europeo intende tutelare la sana competizione, impedendo fusioni verticali. È bene precisare che ne va delle stesse aziende e non solo dei cittadini.
Quando la Cina decise di bloccare l’industria navale, questa legge, in virtù dell’isolamento e dell’uniformità interna (“sotto un unico cielo”), condizionò ogni regione, portando l’impero a ritrovarsi indietro rispetto all’Europa, quando venne il momento di aprirsi ai traffici globali.
Al contrario, il continente europeo è sempre stato frammentato in Staterelli inconciliabili. Qui i popoli hanno sempre attraversato i confini, favoriti dall’assenza di barriere geografiche. Tutto questo ha incentivato scambi, competizione e, perciò, crescita. Un sovrano non avrebbe mai potuto far valere la sua decisione su tutto il continente. Anzi, la forte competitività interna all’Europa ha sempre rappresentato un impulso per lo scambio (furto) di tecniche vantaggiose, l’abbandono di quelle meno avanzate e, quindi, il progresso tecnologico: se un Paese avesse mai scelto di dismettere gli archibugi come accadde in Giappone, sarebbe stato subito invaso, essendo facile preda delle nazioni confinanti, in quell’istante superiori dal punto di vista bellico. L’arcipelago asiatico, invece, lontano da invasori per via della sua posizione geografica isolata, potè scegliere di dismettere le armi da fuoco senza conseguenze, reintroducendo la polvere da sparo solo nella metà del 1800 quando sulle sue coste approdarono le navi statunitensi.
La competizione, allora, rappresenta un incentivo alla tecno-diversità. E’ una terreno di scontro e di compromesso che porta le aziende a convergere verso performance e standard migliori anche per le piattaforme stesse. La varietà tecnologica, la competizione libera e l’assenza di monopoli favoriscono l’emergere di regole bilanciate sulle necessità delle parti; favoriscono la creatività e quindi una tecnologia sempre più varia. E l’eterogeneità è sempre un guadagno. Se ai tempi dei dinosauri non ci fosse stata sufficiente biodiversità, e se i rettili avessero monopolizzato la pluralità faunistica, all’improvviso cambiamento climatico avvenuto 66 milioni di anni fa sarebbe sparita completamente la vita dal Pianeta.
Conclusione
L’arte potrà salvare l’arte dalla censura? La mia risposta è sì. Resta uno strumento di potere, un mezzo per creare consapevolezza e resistenza. Oltretutto se le visualizzazioni sono carburante per le big tech, il diffondersi di video di denuncia, in cui viene dipinta un’immagine negativa delle aziende, può rovinare il loro volume di incasso. Alla luce di ciò, forse non è casuale che Ressler abbia ottenuto la riattivazione dell’account proprio dopo la diffusione della notizia sulla rete.
Le segnalazioni quasi mai vanno a buon fine se la community si limita a indicare gli eventuali abusi attraverso i comandi offerti dalle piattaforme stesse. In presenza di violazioni delle regole, la soluzione migliore sembra essere quella di creare un contenuto di denuncia e postarlo o sulla piattaforma o altrove, nella speranza di diventare virale, ottenendo una diffusa attenzione del pubblico.
Il caso George Floyd, che, a differenza degli altri episodi di violenza perpetrati a danno delle persone di colore, non rimase inascoltato per una ragiona analoga. Quando il filmati di videosorveglianza erano visionati solo dagli agenti americani, gli abusi non venivano quasi mai riscontrati né tanto meno puniti. Al contrario, con George Floyd il video fu diffuso su internet, potendo essere da Paesi distanti culturalmente e in competizione con l’America, che, perciò, avevano addirittura degli interessi a giudicare severamente quegli atti.
La pervasività e il monopolio delle Big Tech vengono affrontati usando quegli stessi trust e invadenza ma a mo’ di armi. In attesa delle tutele del Digital Service Act e degli altri regolamenti, è la creatività che, da buon imprevisto nel determinismo degli algoritmi, si fa salvezza per l’arte stessa.